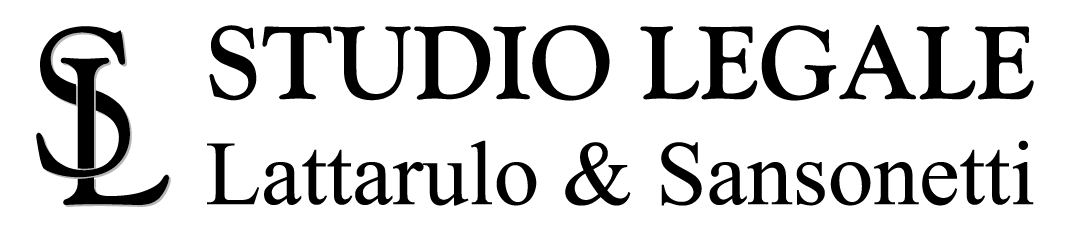Cassazione Civile Sezioni Unite 22 dicembre 2015 n. 25767. La scelta di abortire attiene ad un fatto psìchico, difficilmente provabile, se non per presunzione, tuttavia riguardante circostanze contingenti. La non vita non può essere un bene della vita; l’affermazione di una responsabilità del medico aprirebbe, per coerenza, la strada ad un’analoga responsabilità della stessa madre. Diversamente, una pretesa risarcitoria verso il medico finirebbe con rassegnare al risarcimento del danno un’impropria funzione vicariale, suppletiva di misure di previdenza e assistenza sociale.
Il caso. Una donna aveva partorito sua figlia, risultata affetta da sindrome di Down, sebbene avesse eseguito esami ematochimici a scopo di indagine diagnostica prenatale, proprio ai fine di identificare tale eventuale patologia; il primario ometteva, colposamente, ulteriori approfondimenti, resi necessari dai valori non corretti risultanti dagli esami. Tribunale e Corte d’Appello respingevano la domanda di risarcimento danni.
La decisione. La terza sezione civile, ravvisando un contrasto di giurisprudenza nei precedenti arresti di legittimità, rimetteva la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite. Il tema della nascita indesiderata aveva dato luogo, in ordine alla questione dell’onere probatorio ad un primo e più risalente orientamento, secondo cui corrisponde a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza, se informata di gravi malformazioni del feto (Cass. 6735/2002; 488/2008; 13/2010; 22837/2010; 15386/2011 cui si era contrapposta una giurisprudenza più recente, che aveva escluso tale presunzione semplice, ponendo a carico della parte attrice di allegare e dimostrare che, se informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza (Cass. 16754/2012, 7269/2013; 27528/2013; 12264/2014). Ulteriore contrasto riguardava la legittimazione del nato a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria: alla tesi negativa, sostenuta da Cass. Sez. III 11 maggio 2009 n. 10741, faceva riscontro la contraria opinione che escludeva il requisito della soggettività giuridica del concepito e la sua legittimazione, dopo la nascita, a far valere la violazione del diritto all’autodeterminazione della madre, causa del proprio stato di infermità, che sarebbe mancato se egli non fosse nato (Cass. Sez. III 3 maggio 2011 n.9700; Cass. Sez. III 2 ottobre 2012 n.16754).
In relazione al primo punto, punto di partenza della relativa disamina è l’interpretazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sodale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza), che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità legale di ricorrere all’aborto, legittimando l’autodeterminazione della donna a tutela della sua salute, e non solo della sua vita, pur nel rispetto di condizioni rigorose, espressione di un bilanciamento di esigenze di primaria rilevanza. Il diniego dell’interruzione di gravidanza emerge dall’art. 1, contenente l’enunciazione solenne della gerarchia dei valori presupposta dal legislatore, rivelatrice della natura eccezionale delle ipotesi permissive, fuori delle quali l’aborto resta un delitto (“Lo Stato garantisce ii diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite”) e dall’art. 6: “l’interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata: quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica delia donna”).
Il divieto di aborto indiscriminato, tuttavia, non collima con il principio costituzionale di non equivalenza tra la salvezza della madre, già persona, e quella dell’embrione, che persona deve ancora diventare (Corte cost. 18 febbraio 1975 n.20).
In questa cornice, la sentenza ripropone l’annoso problema del riparto dell’onere della prova dei predetti presupposti di legge in tema di risarcimento dei danni richiesto da nascita indesiderata.
L’impossibilità della scelta della madre è fonte di responsabilità civile.
La gestante, profana della scienza medica, si affida, di regola, ad un professionista, sul quale grave l’obbligo di rispondere in modo tecnicamente adeguato alle sue richieste; senza limitarsi a seguire le direttive della paziente, che abbia espresso, in ipotesi, l’intenzione di sottoporsi ad un esame da lei stessa prescelto, ma tecnicamente inadeguato a consentire una diagnosi affidabile sulla salute del feto.
Occorre però che l’interruzione sia legalmente consentita – e dunque, con riferimento al caso in esame, che sussistano, e siano accertabili mediante appropriati esami clinici, le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna – giacché, senza il concorso di tali presupposti, l’aborto integrerebbe un reato; con la conseguente esclusione della stessa antigiuridicità del danno, dovuto non più a colpa professionale, bensì a precetto imperativo di legge.
Oltre a ciò, dev’essere altresì provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza, in presenza delle specifiche condizioni facoltizzanti.
Sotto questo profilo, il thema probandum è costituito da un fatto complesso; e cioè, da un accadimento composto da molteplici circostanze e comportamenti proiettati nel tempo: la rilevante anomalia del nascituro, l’omessa informazione da parte del medico, il grave pericolo per la salute psicofisica della donna, la scelta abortiva di quest’ultlma.
In tale evenienza, può essere impossibile fornire la dimostrazione analitica di tutti gli eventi o comportamenti che concorrano a comporre fa fattispecie: onde, il problema si risolve ponendo ad oggetto della prova alcuni elementi che si ritengano rappresentativi dell’insieme e dai quali sia perciò possibile derivare la conoscenza, per estrapolazione, dell’intero fatto complesso.
Nel caso in esame un aspetto particolarmente delicato, per la Corte di Cassazione, è costituito dalla circostanza che la prova verte anche su un fatto psichico: e cioè, su uno stato psicologico, un’intenzione, un atteggiamento volitivo della donna, che la legge considera rilevanti. L’ovvio problema che ne scaturisce è che del fatto psìchico non si può fornire rappresentazione immediata e diretta; sicché non si può dire che esso sia oggetto di prova in senso stretto. In tal caso, l’onere probatorio – senza dubbio gravoso, vertendo su un’ipotesi, e non su un fatto storico – può essere assolto tramite dimostrazione di altre circostanze, dalle quali si possa ragionevolmente risalire, per via induttiva, all’esistenza del fatto psichico che si tratta di accertare.
Il passo successivo consiste nell’applicare la concezione quantitativa o statistica della probabilità, intesa come frequenza di un evento in una serie dì possibilità date: espressa dall’ormai consolidato parametro del “più probabile, che non”.
La Corte di Cassazione, al principio dell’ onus incumbit ei qui dicit (e quindi ricadente sulla danneggiata, ex art. 2697 cc, con un riparto che appare del resto rispettoso dei canone della vicinanza della prova), sceglie la strada della possibilità di assolvere il relativo onere in via presuntiva.
È bene chiarire che non si verte in tema di presunzione legale, sia pure juris tantum, la cui consacrazione in via generale ed astratta appartiene al legislatore. Nulla del genere è infatti riscontrabile nella presente fattispecie, in cui il legislatore non esime in alcun modo la madre dall’onere della prova della malattia grave, fìsica o psichica, che giustifichi il ricorso all’interruzione della gravidanza, nonché della sua conforme volontà di ricorrervi. Ci si riferisce, invece, alla praesumptio hominis, rispondente ai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civile, che consiste nell’inferenza del fatto ignoto da un fatto noto, sulla base non solo di correlazioni statisticamente ricorrenti, secondo l’id quod plerumque accidit – che peraltro il giudice civile non potrebbe accertare d’ufficio, se non rientrino nella sfera del notorio (art. 115, secondo comma, cod. proc. civ.) – ma anche di circostanze contingenti, eventualmente anche atipiche – emergenti dai dati istruttori raccolti: quali, ad esempio, il ricorso al consulto medico proprio per conoscere le condizioni di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante, eventualmente verificabili tramite consulenza tecnica d’ufficio, pregresse manifestazioni di pensiero, in ipotesi, sintomatiche di una propensione all’opzione abortiva in caso di grave malformazione del feto, ecc..
In questa direzione il tema d’indagine principale diventa quello delle inferenze che dagli elementi di prova possono essere tratte, al fine di attribuire gradi variabili di conferma delle ipotesi vertenti sui fatti che si tratta di accertare, secondo un criterio di regolarità causale: restando sul professionista la prova contraria che la donna non si sarebbe determinata comunque all’aborto, per qualsivoglia ragione a lei personale.
Il secondo tema affrontato dai giudici di piazza Cavour riguarda la negazione del diritto del figlio, affetto dalla sindrome di Down, al risarcimento del danno per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa, problema più delicato, perchè contrappone due indirizzi di pensiero, di ispirazione anche metagiuridica, fìnanche filosofiche ed etico-religiose, di irriducibile antinomia, segnate da accese intonazioni polemiche in una pubblicistica ideologicamente schierata, in favore o contro la presunzione di preferibilità della vita, per quanto malata (che investe anche temi diversi, come quello della morte pietosa).
La Corte bacchetta il legislatore, ammonendolo che spetta ad esso la disciplina; tuttavia non si sottrae invocandone il ruolo di interprete.
Nucleo centrale della disamina è quello della legittimazione ad agire di chi, al momento della condotta del medico (in ipotesi, antigiuridica), non era ancora soggetto di diritto, alla luce del principio consacrato all’art. l cod. civ. (“La capacità giuridica si acquista da! momento della nascita”), conforme ad un pensiero giuridico plurisecolare.
Natura eccezionale, a questa stregua, rivestirebbero le norme che riconoscono diritti in favore del nascituro, concepito o non concepito, subordinati all’evento della nascita (ibidem, secondo comma): quale deroga al principio generale secondo cui non può reclamare un diritto chi, alla data della sua genesi, non era ancora esistente (artt.254, 320, 462, 784), o non era più (arg. ex art.4 cod. civ.).
Di qui la definizione, nella fattispecie in esame, di diritto adespota, la cui configurazione riuscirebbe, “prima facie” in contrasto con il principio generale sopra richiamato. L’argomento, apparentemente preclusivo in limine, non si palesa, peraltro, insuperabile; e di fatto è stato superato da quella giurisprudenza di legittimità che ha opposto che il diritto al risarcimento, originato da fatto anteriore alla nascita, diventa attuale ed azionabile dopo la nascita del soggetto.
La Corte rivendica il diritto di decidere: “è vero, in tesi generale, che l’attribuzione di soggettività giuridica è appannaggio del solo legislatore, e che la cd. giurisprudenza normativa, talvolta evocata quale fonte concorrente di diritto, violerebbe il principio costituzionale di separazione dei poteri ove non si contenesse all’interno dei limiti ben definiti di clausole generali previste nella stessa legge, espressive di valori dell’ordinamento (buona fede, solidarietà, ecc.), eventualmente riesumando la dicotomia storica tra giurisprudenza degli interessi, di ispirazione evolutiva, e giurisprudenza dei concetti di natura statica: entrambe, peraltro, storicamente ancorate ad una concezione positivistica dei diritto. Ma in realtà – afferma il Supremo Collegio – non è punto indispensabile elevare il nascituro a soggetto di diritto, dotato di capacità giuridica, contro il chiaro dettato dell’art. 1 cod. Civ., per confermare l’astratta legittimazione del figlio disabile ad agire per il risarcimento di un danno le cui premesse fattuali siano collocabile in epoca anteriore alla sua stessa nascita. Al fondo di tale ricostruzione dogmatica vi è, infatti, il convincimento tradizionale, da tempo sottoposto a revisione critica, che per proteggere una certa entità occorra necessariamente qualificarla come soggetto di diritto.
Infatti, la Suprema Corte aveva già da tempo negato che l’esclusione del diritto al risarcimento potesse affermarsi sul solo presupposto che il fatto colposo si fosse verificato anteriormente alla nascita, definendo erronea la concezione che, a tal fine, si ritenga necessaria la sussistenza di un rapporto intersoggettivo ab origine tra danneggiente e danneggiato. Ed ha concluso che, una volta accertata l’esistenza di un rapporto di causalità tra un comportamento colposo, anche se anteriore alla nascita, ed il danno che ne sia derivato al soggetto che con la nascita abbia acquistato la personalità giuridica, sorge e dev’essere riconosciuto in capo a quest’ultimo il diritto al risarcimento (Cass. Sez. III 22 novembre 1993 n. 11503). Tenuto conto del naturale relativismo dei concetti giuridici, alla tutela del nascituro si può pervenire, in conformità con un indirizzo dottrinario, senza postularne la soggettività – che è una tecnica di imputazione di diritti ed obblighi – bensì considerandolo oggetto di tutela (Corte costituzionale 18 febbraio 1975 n.27; Cass., sez.3, maggio 2011 n.9700; Cass. 9 maggio 2000, n. 5881).
Tale principio informa espressamente diverse norme dell’ordinamento. Così, l’art.1, primo comma, legge 19 febbraio 2004 n.40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) annovera tra i soggetti tutelati anche il concepito (“al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti I soggetti coinvolti, compreso il concepito”). Analogo concetto è riflesso nell’art.l della stessa legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), qui in esame, che retrodata la tutela della vita umana anteriormente alla nascita (“Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio). Anche la legge 29 luglio 1975 n.405 (Istituzione dei consultori familiari) afferma l’esigenza di proteggere la salute del concepito (art.l: “Il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità ha come scopi…: c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento”). Infine, nell’ambito della stessa normativa codicistica, l’art.254 prevede il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio anche quando questi sia solo concepito, ma non ancora nato.
Entro questa cornice dogmatica si può dunque concludere per l’ammissibilità dell’azione del minore, volta ai risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione. Tesi, che del resto neppure collide con la teoria della causalità, posto che è ben possibile che tra causa ed evento lesivo intercorra una cesura spazio-temporale, tale da differire il relativo diritto al ristoro solo al compiuto verificarsi dell’effetto pregiudizievole, purché senza il concorso determinante di concause sopravvenute ( cfr. art.41 cod. pen.).
Tuttavia, il caso oggetto della presente disamina, è particolare, perchè il medico è, in ipotesi, l’autore mediato del danno, per aver privato la madre di una facoltà riconosciutale dalla legge, tramite una condotta omissiva che si ponga in rapporto diretto di causalità con la nascita indesiderata; e la soluzione verrebbe, in tal modo, ad essere identica alla diversa ipotesi della responsabilità del medico verso il nato disabile per omessa comunicazione ai genitori della pericolosità di un farmaco somministrato per stimolare l’attività riproduttiva (Cass 2009 n. 10741), o di una malattia della gestante suscettibile di ripercuotersi sulla salute del feto.
Se dunque l’astratta riconoscibilità della titolarità di un diritto (oltre che della legittimazione attiva) del figlio handicappato non trova un ostacolo insormontabile nell’anteriorità del fatto illecito alla nascita, giacché si può essere destinatari di tutela anche senza essere soggetti dotati di capacità giuridica ai sensi dell’art.l cod. civile, occorre scrutinare a fondo il contenuto stesso del diritto che si assume leso ed il rapporto di causalità tra condotta del medico ed evento di danno. Sotto il primo profilo, sì deve partire dal concetto di danno-conseguenza, consacrato all’art.1223 cod. civile e riassumibile, con espressione empirica, nell’avere di meno, a seguito dell’illecito. In siffatta ricostruzione dogmatica, il danno riuscirebbe pertanto legato alla stessa vita del bambino; e l’assenza di danno alla sua morte. Ed è qui, secondo le Sezioni Unite, che la tesi ammissiva, in subìecta materia, incorre in una contraddizione insuperabile: dal momento che il secondo termine di paragone, nella comparazione tra le due situazioni alternative, prima e dopo l’illecito, è la non vita, da interruzione della gravidanza. E la non vita non può essere un bene della vita; per la contraddizione che nol consente.
Tanto meno può esserlo, per il nato, retrospettivamente, l’omessa distruzione della propria vita (in fieri), che è il bene per eccellenza, al vertice della scala assiologica dell’ordinamento.
Non si può dunque parlare di un diritto a non nascere; tale, occorrendo ripetere, è l’alternativa; e non certo quella di nascere sani, una volta esclusa alcuna responsabilità, commissiva o anche omissiva, del medico nel danneggiamento del feto. Allo stesso modo in cui non sarebbe configurabile un diritto al suicidio, tutelabile contro chi cerchi di impedirlo: ché anzi, non è responsabile il soccorritore che produca lesioni cagionate ad una persona nei salvarla dai perìcolo di morte (stimato, per definizione, male maggiore). Si aggiunga, per completezza argomentativa, che seppur non è punìbile il tentato suicidio, costituisce, per contro, reato l’istigazione o l’aiuto al suicidio (art.580 cod. pen.): a riprova ulteriore che la vita – e non la sua negazione – è sempre stata il bene supremo protetto dall’ordinamento.
Del resto, il presupposto stesso del diritto è la vita del soggetto; e la sua centralità affermata fin dal diritto romano (“Cum gitur hominum causa omne ius constitutum sit… D. 1, 5, 2., Hermogenianus, libro primo iurìs epitomarum ).
Il supposto interesse a non nascere, com’è stato detto efficacemente in dottrina, mette in scacco il concetto stesso di danno. Tanto più che di esso si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell’attribuire alla volontà del nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia; come tale, indegna di essere vissuta (quasi un corollario estremo dei cd. diritto alla felicità). L’ordinamento non riconosce, per contro, il diritto alla non vita: cosa diversa dal cd. diritto di staccare la spina, che comunque presupporrebbe una manifestazione positiva di volontà ex ante (testamento biologico). L’accostamento, non infrequente, tra le due fattispecie è fallace; oltre a non tener conto dei limiti connaturali al ragionamento analogico, soprattutto in tema di norme eccezionali.
Né vale invocare il diritto di autodeterminazione della madre, leso dalla mancata informazione sanitaria, ai fini di una propagazione intersoggettiva dell’effetto pregiudizievole (Cass., sez. 3, 3 maggio 2011, n.9700). La formula, concettualmente fluida ed inafferrabile, pretende di estendere al nascituro una facoltà che è concessa dalla legge alla gestante, in presenza di rigorose condizioni – progressivamente più restrittive nel tempo – posta in relazione di bilanciamento con un suo diritto già esistente alla salute personale, che costituisce il concreto termine di paragone positivo: bilanciamento, evidentemente non predicabile, in relazione al nascituro, con una situazione alternativa di assoluta negatività.
In senso contrario, qualche voce in dottrina, non senza echi giurisprudenziali, adduce l’apparente antinomia tra la progressiva estensione del credito risarcitorio in favore del padre (Cass., sez.3, 10 maggio 2002 n.6735) e dei germani (Cass., sez.3, 2 ottobre 2012 n. 16.754) ed il perdurante diniego opposto al figlio, primo interessato dalle patologie prese in considerazione dalla norma: argomento, suggestivo ed impressionistico, ma di nessun pregio giuridico, restando ad un livello di costatazione empirica, senza adeguato apprezzamento delle diverse premesse in diritto.
La Corte mostra tuttavia di essere a disagio nell’emettere una pronuncia così importante e si appella a pronunce di giudici stranieri. Le Corti superiori nella maggior parte degli stati degli U.S.A. hanno respinto le richieste risarcitorie dei figli handicappati, accogliendo invece quella dei genitori (cfr. New Jersey Supreme Court 26 giugno 1979, Berman v. Allan). Anche in Germania, si è negato il risarcimento al figlio handicappato (BGH, 18 gennaio 1983); così come in Inghilterra (London Court of Appeal 19 febbraio 1982, Sachen McKay v. Essex Health Authority).
Alla luce di questi cenni sommari, si può enucleare una tendenza generale a ritenere compensabile la penosità delle difficoltà cui il nato andrà incontro nel corso della sua esistenza, a cagione di patologie in nessun modo imputabili eziologicamente a colpa medica, mediante interventi di sostegno affidati alla solidarietà generale; e dunque, nella sede appropriata alla tutela di soggetti diversamente abili e bisognosi di sostegno per cause di qualsivoglia natura, anche diversa da quella in esame.
Né può essere sottaciuto, da ultimo, il dubbio che l’affermazione di una responsabilità del medico verso il nato aprirebbe, per coerenza, la strada ad un’analoga responsabilità della stessa madre, che nelle circostanze contemplate dall’art.6 legge 194/1978, benché correttamente informata, abbia portato a termine la gravidanza: dato che riconoscere il diritto di non nascere malati comporterebbe, quale simmetrico termine del rapporto giuridico, l’obbligo della madre di abortire.
Il contrario indirizzo giurisprudenziale e dottrinario, favorevole alla riconoscibilità di una pretesa risarcitoria del nato disabile verso il medico, finirebbe con rassegnare al risarcimento del danno un’impropria funzione vicariale, suppletiva di misure di previdenza e assistenza sociale.
Non senza soppesare altresì il rischio di una reificazione dell’uomo, la cui vita verrebbe ad essere apprezzabile in ragione dell’integrità psico-fisica: deriva, quindi, eugenica.
Avv. Carmine Lattarulo
E’ possibile provare per presunzioni la scelta dell’aborto se il feto è down; inesistente il diritto a non nascere, se non sani.
Articolo precedente